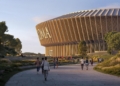Il calcio si rifugia spesso nel luogo comune e nel preconcetto. Qualcuno faticherà a crederci, ma è lo stesso Daniele De Rossi che al Mondiale 2006 aprì l’arcata sopraccigliare a McBride con una gomitata (per contendergli il pallone, non a gioco fermo: differenza fondamentale). Allora era il «bullo di Ostia» e il c.t. Marcello Lippi avrebbe dovuto mandarlo a casa, in virtù di un giustizialismo da forca in piazza che da allora è diventato sempre più di moda. De Rossi sbagliò, pagò con una lunga squalifica e rientrò per la finale contro la Francia, dove segnò senza paura uno dei rigori finali. «Non ho mai pensato a cosa sarebbe successo se avessi sbagliato — raccontò poi —. Però, se non avessi tirato, non avrei mai potuto considerarmi un campione del mondo». Dopo il gol sibilò a Barthez un romanissimo: «E mo’ buttace li guanti!». Daniele (o Lele, come lo chiama Buffon da uomo del Nord) adesso è il saggio che esce a testa alta dalla sconfitta più amara.
E invece è sempre lo stesso DDR, che non ha mai deviato dal suo personalissimo vangelo calcistico, quello che in campo «gli fa ogni tanto gonfiare la vena» (il copyright è suo) ma che in passato gli ha fatto confessare all’arbitro di aver segnato un gol di mano. Il calcio è sacro e nei riti convivono pace e violenza, trascendenza e impeto terreno. Figlio di allenatore — papà Alberto è uno dei più bravi e vincenti d’Italia a livello giovanile — De Rossi un giorno allenerà. Magari la Roma, magari la Nazionale. Ha avuto grandi rapporti con tutti i suoi tecnici: da Capello a Luis Enrique, da Spalletti a Garcia, fino a Conte e Di Francesco. Da tutti ha imparato qualcosa, solo con Zeman non è mai scattato il feeling. Gli svedesi, raccontando il fatto del pullman, hanno fatto conoscere un De Rossi diverso, ma solo a chi non lo conosceva già. Un giorno disse a un giornalista: «Se nello spogliatoio della Roma cade una moneta, voi non lo dovete venire a sapere». Giocatore, allenatore, dirigente e addetto stampa. Tutto in uno.